Man mano che il software si mangia il mondo (l’icastica espressione è di Marc Andreessen), man mano cioè che sono i modelli di business delle piattaforme digitali a decidere cosa si fa nel mondo e come lo si fa, togliendo spazio alla politica e alla società civile attraverso l’implacabilità di un nuovo logos dalla doppia natura finanziaria e tecnologica che nulla ha a che vedere con i meccanismi della delega e della rappresentatività tipica dei corpi intermedi della democrazia benché ne imiti le forme esteriori (ad esempio la self-regulation), diventa sempre più essenziale capire come il software “funzioni”.
Mi sembra però evidente che il coding come lo si insegna nelle scuole del belpaese stia ben attento a presentarsi come riedizione posh di quell’informatica anni ’90 di cui ha preso il posto: tenendosi sufficientemente alla larga tanto dai tecnicismi quanto da tutto ciò che può essere in odore di cultura economico-organizzativa, da sempre invisa alla scuola pubblica italiana. Riuscendo nel frattempo a strizzare l’occhio alle paure di genitori, che non capendoci molto si lasciano lusingare dalla promessa di un passi esclusivo nel mondo del lavoro che verrà. Così non si va da nessuna parte.
Il coding, se vogliamo che parlarne a scuola serva non a compiacere mode passeggere ma a formare cittadini consapevoli in un mondo che di qui a 10 anni è difficile prevedere dove andrà, deve intersecare l’educazione alla cittadinanza digitale (una buona base di partenza è l’art. 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92) ma soprattutto deve fornire gli strumenti indispensabili a confrontarsi con il mondo reale, a capirlo, a decifrarne la complessità. La scuola non deve vendere illusioni, non deve convincerci che il coding sia divertente e glam, perché semplicemente non è vero: il coding, che lo si pratichi per lavoro o lo renda parte integrante di una nuova paideia, impone lo sviluppo di una forma mentis addirittura innaturale, perché è la mente umana che deve adattarsi alla macchina e non viceversa. Ad onta di tutti i linguaggi di alto livello, dei framework, dei tool visuali, programmare è tra le attività meno “ergonomiche” che l’uomo conosca. Dedizione e spirito di sacrificio sono imprescindibili, a meno che non vogliamo che lo studio del coding ricalchi le orme vergognose dell’educazione musicale: tre note stonate al flauto e i ragazzi che non sanno distinguere Bach da Pupo.
Pasolini, ricordo, metteva in guardia contro gli approcci naïf al linguaggio tecnico, perché è in esso che vivono le specificità dei saperi. Ma nel coding non c’è soltanto il tecnicismo: ci sono una cultura, pratiche, modelli organizzativi, riti, impatto sociale e impatto economico. Serve quindi non tanto (o non soltanto) l’ennesima rivisitazione di un pensiero logico-computazionale variamente declinato, ma un’educazione agli elementi per così dire “meta” del software. L’algoritmo è sempre politico.
La vicenda Immuni ha dimostrato che saper comprendere il coding rappresenta il discrimine tra chi è in grado di farsi un’idea di prima mano anche su questioni di interesse nazionale e chi invece non ha difese rispetto a un deluge informativo contraddittorio e avvelenato da interessi di parte. Personalmente mi ha fatto veramente impressione l’assoluta mancanza di competenza sulla grammatica non dico tecnologica ma sociale ed economica del software dimostrata dalla nomenklatura dell’Italia sedicente aggiornata sul “digital”, arroccata sulla linea maginot di diritti che nessuno minacciava perché ovviamente gridare alla violazione degli stessi nel paese degli azzecarbugli paga ancora, che ha strepitato di mancanza di una strategia senza comprendere che la strategia si articolava appunto nell’adozione di una soluzione digitale insieme all’interno di un processo più ampio (test treat trace) e che comunque le decisioni di fondo erano già state prese da Apple e Google ed “imposte” alla politica attraverso il soft power (o vogliamo chiamarlo nudging?) irresistibile del mercato e della dominanza tecnologica. Che quelle piattaforme si stavano comunque accreditando anche attraverso l’exposure notification come agorà globali, così come è agorà la piattaforma di sviluppo collaborativo GitHub su cui sono stati pubblicati i codici sorgenti di Immuni, non certo per sudditanza verso Microsoft che ne detiene la proprietà ma semplicemente perché la “lex digitalis”, cioè le dinamiche intrinseche del mercato tech globale, non conoscono che due o tre opzioni (l’altra era GitLab scelta dall’Inria per l’app francese StopCovid).
E poi c’è l’eterno tema dell’open source, su cui non posso non ritornare almeno con la frequenza con cui Michele Serra negli anni d’oro sfogava nelle sue ‘Amache l’amore-odio per il Cavaliere’. Perché ormai nell’open source la mia vita è completamente immersa: lo uso, lo leggo, lo scrivo. Come tanti altri, del resto, come tutti anzi, perché l’open source è l’infrastruttura immateriale su cui si regge l’infosfera. E ne parlo, sì, perché parlare e interrogarsi sul senso di quello che si fa non è meno importante che farlo. Ho imparato negli anni ad apprezzare, dell’open source, la cultura e i vantaggi. E ovviamente i limiti.
Il limite principale, nel momento in cui si vuol calare quel modello in un mondo come quello della pubblica amministrazione che ha logiche diverse dalla ricerca e dall’industria, è che l’operazione resta monca se ci si limita ad usare o “riusare” soluzioni open senza che l’intera gestione avvenga in ottica open; senza che ogni correzione, modifica, adattamento vengano reimmessi nel ciclo di vita globale della soluzione, e quindi prima di tutto pensati per essere fruiti anche da soggetti esterni. I total cost of ownership diventano difficilmente giustificabili se non all’interno di una dinamica intrinsecamente circolare in cui ciascuno snodo del sistema è sia fruitore che produttore. Su questo punto però non mi sembra insistano adeguatamente gli articoli 68 e 69 del nostro Codice dell’Amministrazione Digitale, i quali sono scritti più nell’ottica di una pubblica amministrazione committente, ossia nel quadro del procurement publico di soluzioni ICT (pur nell’obbligo di mettere a disposizione di altri enti le soluzioni acquistate) che non dal punto di vista di una pubblica amministrazione che partecipa attivamente e consapevolmente alla costruzione di un ecosistema digitale globale. Sì, perché l’open source ha intrinsecamente una caratterizzazione globale: qualsiasi tentativo di addomesticarlo alle logiche di tipo localistico o regionalistico è una forzatura destinata a fallire perché i costi sono troppo alti.
Poi ci sono i dulcamara che invitano l’opinione pubblica a non occuparsi di queste questioni perché sarebbero “da tecnici”: come a dire “ci pensiamo noi”. La Parabola dei ciechi di Pieter Bruegel il Vecchio è un’allegoria perfetta di questa situazione.



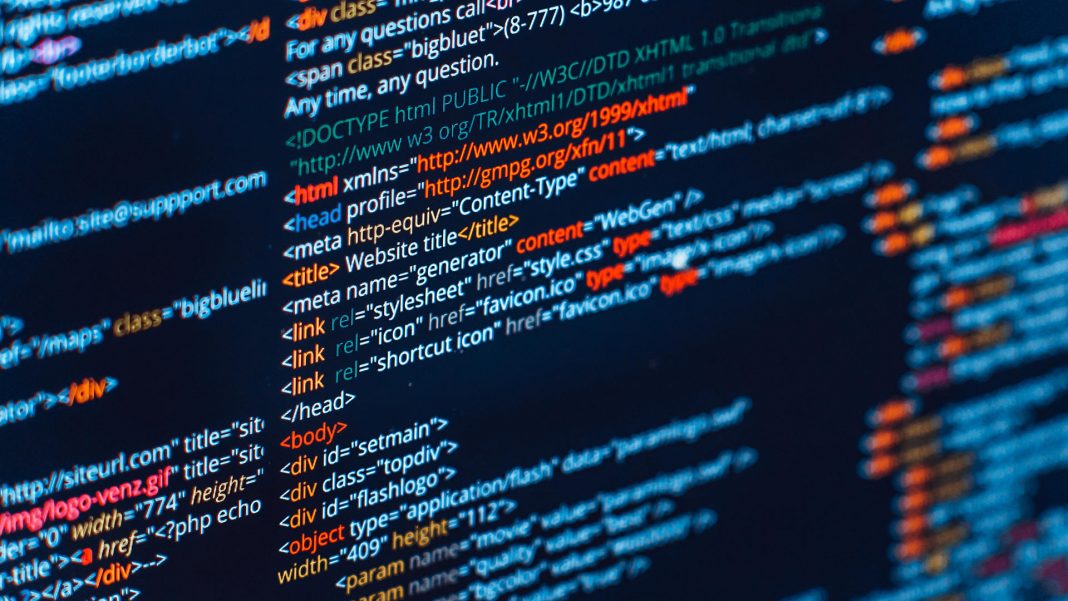


Hello there! I simply want to offer you a huge thumbs up
for the great info you have here on this post.
I will be coming back to your web site for more soon.
Review my web page – blog